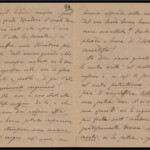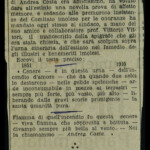Introduzione
Se c’è un aspetto in cui l’immagine di Pascoli deve essere riveduta e corretta rispetto alla vulgata biografica e scolastica, questo è senz’altro il rapporto che egli intrattenne con le idee politiche del suo tempo, prime fra tutte quelle socialiste. Partendo dagli anni della formazione a Bologna tra il 1873 e il 1882, allorché l’impegno del poeta nelle file dell’Internazionale anarchica di Andrea Costa assunse, per intensità e convinzione, le caratteristiche di una vera e propria militanza; fino ad arrivare alla stagione del suo socialismo maturo, un socialismo umanitario, patriottico, persino cristiano, perfezionato fino a immetterlo nelle retoriche implicazioni del nazionalismo, e ormai lontano anni luce da quello anarco-insurrezionalista di stretta osservanza.
Parlare di un Pascoli socialista trova validità nella storia stessa dell’uomo, nella vicenda personale di un artista che sempre si considerò senza infingimenti socialista, per quanto non ortodosso.
Il Pascoli degli anni maturi sapeva bene che il suo credo socialista non era più quello rivoluzionario – e inevitabilmente violento – della giovinezza: in prima persona vi aveva lavorato per mutarlo, per ridurlo a misura di concetti come carità, fratellanza e concordia umana, concetti che da tempo ormai erano divenuti i cardini attorno cui ruotava il suo sistema di pensiero; eppure ciò non gli impediva di continuare a proclamarsi, sebbene sui generis (ma un genere che da individuale solamente auspicava divenisse patrimonio di tutta l’umanità), socialista.
È innegabile nell’opera pascoliana la presenza di quella che Mario Pazzaglia chiama “una sottile linea rossa”, ovvero una ripresa di spunti e temi che si potrebbero definire genericamente socialisti, cioè non limitati alle ideologie internazionaliste giovanili, e neppure a quelle nazionaliste adulte, piuttosto semplicemente generate da un autentico bisogno di giustizia sociale e da un sogno di palingenesi umana.
Galleria
Il percorso “Pascoli e la politica” è stata redatto da Alice Cencetti nel dicembre 2012.
La giovinezza anarchica
Per decenni la critica ha sentito l’esigenza di ridimensionare l’esperienza politica rivoluzionaria fatta dal poeta durante i suoi anni universitari, smorzandone i toni e mettendone perfino in dubbio la serietà e l’autenticità, per risolvere l’aporia che si veniva a determinare tra due momenti esistenziali – giovinezza e maturità – così diversi tra loro. A tal segno diversi, che si è più volte sostenuto che, pure nel suo periodo internazionalista, Pascoli rifuggiva da ogni forma di violenza così come avrebbe poi fatto negli anni successivi, spiegando alcune sue parole e atteggiamenti come una forma di emulazione di più incisivi e carismatici compagni. In realtà, tuttavia, le ricerche d’archivio intensificate dalla fine degli anni Novanta ci consegnano l’immagine di un ventenne disinteressato agli sbocchi professionali del suo titolo di studio, incurante di un’eventuale carriera scolastica, per non dire del suo prolungamento accademico (sub specie carducciana), propenso più che altro a un impegno di giornalista o addirittura di intellettuale di partito; e la famiglia, quel famoso nido, mito tutto nazionalpopolare, da un tale impianto di vita rimane, o rimarrebbe, esclusa, nel senso che in ben nove anni Pascoli, pur tornando periodicamente in Romagna, non andò mai a trovare una sola volta le sorelle in convento a Sogliano, e neppure risulta che fosse con loro in contatto epistolare. Una posizione aggravata dal fatto che nel 1876 moriva Giacomo, e il testimone di “piccolo padre” sarebbe dovuto passare nelle sue mani. Un vero enigma sotto il profilo biografico, non vi è dubbio, stante la centralità e la funzione strutturale di sostegno e di indirizzo che il nido acquisì nella vita, e in parte nella poesia. Anche nella politica.
Giovanni approda a Bologna nel novembre 1873. E Bologna è insieme la città universitaria di Carducci e la roccaforte anarco-socialista di Andrea Costa. Il politico imolese era di quattro anni più anziano di Pascoli e dal 1870 iscritto alla Facoltà di Lettere. Quando Giovanni conobbe Costa non è possibile determinarlo con certezza, anche perché non v’è accordo tra le fonti: secondo la sorella Maria la conoscenza risale al 1876, mentre secondo un compagno internazionalista, Gaetano Zirardini, Giovanni fu internazionalista fin dal 1874. Maria stessa, che è solitamente molto cauta nello sfiorare l’impegno socialista del fratello, ammette che «i loro ideali di umana e sociale giustizia, il loro amore per tutto ciò che è bello e buono e la loro povertà li legarono subito in amicizia», per quanto poi, come correttivo, affermi che il sentimento socialista di Giovanni nulla aveva a che fare con l’internazionalismo di Costa, per non dire con il comunismo di Marx. E sull’estraneità al marxismo teorico certo si deve concordare.
Pascoli fu dichiaratamente quanto spontaneamente refrattario allo scientismo rivoluzionario e intese la lotta politica, finché fu lotta, finché conservò le stigmate di un conflitto, come partecipazione, solidarietà, personale coinvolgimento. La rivoluzione era in un certo senso la proiezione attiva della propria autobiografia di umile orfano oltraggiato dalla violenza della storia, e dall’ingiustizia. Poi, a maturità raggiunta, un’età stanca, arresa, quel fervore, cui non era stato estraneo un ceppo di genuina violenza, lasciò il posto a un armonico e per certi aspetti velleitario disegno di irenismo universale.
Sono stati gli studi inaugurati negli anni ’60 da Renato Zangheri, quindi proficuamente proseguiti da Elisabetta Graziosi, a fare luce sull’effettivo impegno prestato dal poeta nelle file dell’Internazionale: i documenti conservati nell’Archivio di Stato di Bologna consegnano l’immagine di un giovane rivoluzionario, sempre in prima fila qualora si tratti di organizzare riunioni clandestine, aiutare Costa durante la sua latitanza, tenere conferenze per i compagni, scrivere e diffondere volantini e manifesti. E se nel 1875 perse la borsa di studio, non fu, come racconta Maria, per l’arrogante risposta data in seguito alle manifestazioni contro il Ministro della Pubblica Istruzione Bonghi; ma, più banalmente, perché non aveva dato tutti gli esami necessari per mantenerla, quella borsa di studio.
Alla frequenza delle lezioni non era molto interessato, neppure a quelle di Carducci, con cui, per sfatare un altro mito biografico, i rapporti non erano poi così idilliaci. Il fatto che nell’80 il poeta riprenda in mano il progetto di laurearsi a Firenze testimonia che Carducci e l’università non erano i motivi che lo inducevano a restare a Bologna; e se non darà un seguito effettivo al suo disegno è solo perché a Firenze non avrebbe avuto mezzi di sostentamento. La permanenza di Pascoli a Bologna è a tal punto dovuta all’amicizia con Costa e al suo impegno politico, che i periodi in cui quest’ultimo si trovò in carcere o all’estero sono quasi tutti sovrapponibili a quelli in cui Giovanni esternò di volersi trasferire altrove.
Tutte le scelte di Giovanni dal momento della perdita del sussidio e quindi dall’inizio della fase centrifuga a quello della ripresa degli studi nel 1880 sono indubbiamente legate alle sue idee politiche internazionaliste, compresa quella dell’attività giornalistica: il suo impegno nelle file dell’Internazionale conoscerà un’intensificazione a partire appunto dal 1875, fino ad arrivare all’arresto nel 1879. Dopo questa data, tuttavia, il suo attivismo politico non andrà incontro ad una brusca interruzione, semplicemente si manifesterà in forme pratiche e teoriche mutate, e la ragione di ciò non andrà cercata soltanto nella traumatica esperienza del carcere, né tanto meno in ragioni soggettive o psicologiche, ma in mutamenti del mondo politico che proprio allora si stavano verificando.
Negli anni della militanza la produzione poetica pascoliana si muove su un doppio binario, quello delle riviste letterarie come “Pagine Sparse” e i “Nuovi Goliardi”, e quello delle testate internazionaliste come “Il Martello” di Costa e “Il Nettuno” di Domenico Francolini, sul quale il 17 febbraio 1878 pubblicava La morte del ricco, una poesia dai contenuti funzionali per chiarezza argomentativa alla propaganda politica: in essa tornano come in una processione di ombre tutte le figure protagoniste dell’ideologia socialista, la donna sedotta e abbandonata, il figlio illegittimo, il contadino sfruttato, il minatore morto sul lavoro, il soldato costretto ad essere uccisore e poi ucciso, e infine una serie di spettri che accusano di aver patito la fame e il freddo.
Di tutto, si noti il titolo della composizione, è responsabile la ricchezza, l’accumulo, in una parola il capitale. E ancora nel ’78 Pascoli scriverebbe, secondo la testimonianza di alcuni compagni del tempo, la cosiddetta Ode a Passanante, per celebrare l’impresa del cuoco anarchico potenziale regicida, un componimento per cui è d’obbligo usare il condizionale, dal momento che non è giunto fino a noi e secondo Maria addirittura non fu il fratello a scriverlo.
Il 1878 si configura indubbiamente come l’anno in cui l’impegno politico pascoliano raggiunge il suo apice, come pare attestare anche un vero e proprio inno socialista anarchico intessuto dei motivi del catastrofismo utopico anarchico, con un contenuto ad alto tasso di violenza sanguinaria (“sol rida chi ha posto le mani nel sangue”), in cui l’Internazionale viene presentata come alba di un nuovo giorno per l’umanità, come realizzazione di un desiderio di vendetta e libertà. E questo è appunto l’anno in cui le carte di polizia registrano tutti gli spostamenti del poeta continuamente pedinato. Tutto ciò fino al 7 settembre 1879, giorno in cui Pascoli viene arrestato per aver manifestato contro la sentenza di condanna per alcuni internazionalisti imolesi accusati di manifestazioni sovversive a favore di Passanante. Resterà in carcere per circa cento giorni, fino al 22 dicembre, allorché verrà rilasciato, prosciolto da ogni accusa.
La frase da lui pronunciata durante un interrogatorio (“Le mie idee mi conducono ad appartenere a quella parte di socialisti che desiderano il miglioramento della società senza pervertimento dell’ordine”) è stata per molto tempo considerata la prova del suo non essere mai stato un vero rivoluzionario, del non aver mai preso sul serio l’attività politica, e dunque ecco spiegata l’altrimenti inspiegabile e repentina decisione di riprendere gli studi, dare gli esami mancanti e laurearsi. Ma se è vero che questa svolta biografica ci fu, bisognerà comunque ricordare che fino alla laurea l’impegno politico non cessò, e che questa svolta trova la sua vera spiegazione ancora una volta in ragioni di ordine politico. Né poteva essere altrimenti, considerato il fatto che Giovanni aveva vissuto la sua passione politica all’interno di una meglio gioventù fatta di sodali molto affiatati, guidati e motivati dal princeps iuventutis Andrea Costa. E proprio Costa il 27 luglio 1879 aveva scritto la lettera Ai miei amici di Romagna, un documento che sanciva la necessità dell’uscita dell’internazionalismo dalle secche dell’anarchismo in direzione della prossima svolta legalitaria dell’82. In quella lettera, documento periodizzante nella storia del movimento operaio, il leader socialista proclamava che la rivoluzione restava come fine, non era più il mezzo, giacché i tempi non erano ancora maturi per la liquidazione sociale, e piuttosto si doveva tornare al popolo e immergersi in esso, indagandone i bisogni, conoscendolo più a fondo, altrimenti con l’idea della rivoluzione ad ogni costo il socialismo avrebbe rischiato di estinguersi in un vortice di violenza.
Costa di fatto accusò, in quanto la sua fu anche un’autocritica, il movimento di autoreferenzialità. E lo indirizzò in direzione della società, nelle sue plurime versioni ambientali e professionali (a cominciare dalla scuola, dall’istruzione pubblica, che fu il ruolo assegnato a Pascoli), per una sorta di pragmatica quanto matura neoevangelizzazione ideologico-politica, che conseguì effetti duraturi e decisivi nel creare una opposizione legale a uno Stato oligarchico.
La legalità, come necessità per far rientrare in gioco il movimento, per rendere nazionale l’internazionale, attiva e utile l’anarchia altrimenti dispersa nei mille rivoli di un attivismo a rischio di inconcludenza, fu la grande intuizione di Costa, e tutti o quasi rientrarono in quell’alveo. Perciò se Giovanni stava cambiando, in realtà si apprestava a seguire il passo delle cose che cambiavano intorno a lui. Al modo in cui Costa, da rivoluzionario quale era stato, nel 1882 diveniva il primo deputato socialista della storia italiana, Pascoli aveva attuato il suo personale ritorno all’ordine laureandosi il 17 giugno dello stesso anno, e già dai primi di ottobre intraprendendo la carriera di insegnante con destinazione Matera: il suo impegno politico non era ancora venuto meno, anche se stava assumendo forme diverse che poi si sarebbero compiutamente realizzate nel suo socialismo maturo.
Galleria


La politica della maturità
Dopo la laurea è quasi certo che Costa e Pascoli non ebbero più contatti diretti. E ai fini dell’elaborazione del suo nuovo pensiero politico giocò invece un ruolo fondamentale la possibilità di parlare da una cattedra universitaria, da Messina a Bologna, soprattutto quando a Bologna si sentì il diritto e il dovere di proseguire – originalmente – la funzione già carducciana di cantore delle imprese nazionali.
Il socialismo pascoliano andrà progressivamente modificandosi, abbandonando la portata rivoluzionaria del verbo anarchico, e accogliendo invece implicazioni umanitarie e patriottiche (patria come famiglia, patria come nido), che non rinunciavano a tingersi di sfumature addirittura nazionalistiche. Nazionalismo che mascherava l’offesa bellicista insita nel suo verbo con la copertura vittimistico-autotutoria di un difensivismo della forza-lavoro, la quale, in eccesso, poteva sgorgare, liberarsi e liberare, per le vie di un imperialismo bracciantile. Che fosse genuino il suo pensiero, non toglie che risultasse e ancora risulti equivoco all’analisi storica. Certo il poeta continuò a sentirsi sempre e sinceramente socialista, inoppugnabilmente a parte subiecti, almeno da un punto di vista di affinità sentimentale, se non proprio di ortodossia politica, e questo anche per ragioni di proiezione autobiografica, là dove l’autobiografia, nel caso pascoliano, risultava sempre piuttosto ingombrante, e in fin dei conti dettava lo spartito all’idea: «io sono stato sempre misero, e sto coi miseri; io ho patito l’ingiustizia, e non sto con quelli che la giustizia non fanno», aveva scritto nella Lettera a Lucifero, pubblicata sul «Proletario» di Messina l’8 dicembre 1900.
Quella che era venuta meno era la condivisione ideologica circa il principio della rivoluzione e della lotta di classe, giacché, a suo dire, l’Italia era priva di classi, essendoci piuttosto una piccola borghesia sempre sul punto di varcare la soglia dell’indigenza e dunque del proletariato, incapace di vivere all’altezza delle aspettative e impossibilitata perfino a maritare le proprie figlie (e qui come non pensare al caso della sorella Maria). Non solo. Perché anche la piccola proprietà, sub specie della siepe, andava salvaguardata: non aveva alcun senso augurarsi la proletarizzazione dei piccoli proprietari terrieri, così come non aveva alcun senso augurarsi di far soffrire nel presente uno, foss’anche per far godere, nel futuro, tutti quanti.
Per Pascoli la lotta doveva essere spostata piuttosto sul piano dei conflitti tra nazioni, in quanto esistono nazioni proletarie e nazioni imperialistiche, e le prime rispetto alle seconde hanno il diritto di rivendicare il loro posto al sole: le nazioni devono perciò essere sostenute contro gli imperi-simboli del dominio capitalistico, evitando così che i singoli popoli vengano assorbiti dai più forti fino a dare luogo a un unico impero terracqueo.
È il verbo del «socialismo patriottico» – formula ossimorica quant’altre mai, ma non nella visione pascoliana – teorizzato nel discorso Una sagra pronunciato a Messina nel 1900. Questi sono i presupposti ideologici che sottostanno al celeberrimo discorso dedicato alla campagna di Libia del 1911, La grande Proletaria si è mossa (Barga, 21 novembre 1911), in cui il poeta, ormai da circa un lustro titolare della cattedra carducciana di Bologna, contiguo ai luoghi del vatismo più ufficiale, emulo quindi di quel ruolo di tribuno italico rivestito per decenni dall’antico maestro, prendeva posizione a favore dell’impresa coloniale, in questo accordandosi ad alcune posizioni dell’opinione pubblica del tempo in un’Italia ancora dilaniata da irredentismo e volontà di diventare Stato moderno.
La conquista della Libia, infatti, era stata accolta con favore in quanto si sarebbe configurata come potenziale sbocco per tutti quei lavoratori che così non sarebbero più stati costretti ad emigrare in terre straniere dove essere sopportati e discriminati, ma avrebbero continuato a soggiornare sul suolo patrio. In quella sua protesi imperiale. Si tratta di posizioni con venature evidentemente nazionalistiche, che tante critiche attireranno al pensiero pascoliano, prime fra tutte quelle di ex compagni internazionalisti come il già citato Domenico Francolini. In questo caso il poeta forse peccò di scarso senso della realtà, perché non mise nel conto dell’impresa quello che essa costò in termini di vite umane innocenti, un costo che mal s’accordava con la sua visione palingenetica di un’umanità che avrebbe dovuto incamminarsi verso un futuro di felicità in quanto incremento di sentimento di carità e pietà nel cuore dell’uomo: ma il suo utopistico colonialismo, così come l’aveva teorizzato e predicato, avrebbe dovuto essere di lavoro e non di sfruttamento, avrebbe dovuto servire e aiutare, non prevaricare. Un dover essere, un voler essere, che non si conciliava al paradigma di realtà. Irrealismo pacifista, anzi utopismo pacificatore, applicato alla guerra, questa la grande e non superabile aporia, tipica di una mente come quella pascoliana, non addestrata al realismo se non a quello della poesia.
Se l’imperialismo di d’Annunzio fu marcatamente crudele, quello di Pascoli fu buono. Proprio nel discorso L’avvento (Messina, 1901), Pascoli definisce il socialismo come «fenomeno d’altruismo», come un fatto di carità e d’amore, movimento politico che ha avuto il merito d’inaugurare un nuovo regno della pietà, in cui, ancora una volta, non avrebbero avuto peso le divisioni di classe, perché l’elevazione delle singole classi sarebbe avvenuta comunque per opera di quelle superiori, in una moderna concordia ordinum. «Ecco la base del mio socialismo: il certo e continuo incremento della pietà nel cuore dell’uomo»: l’unica lotta che è legittimo combattere sarà dunque quella da ognuno ingaggiata con se stesso qualora non riesca a conformarsi all’ideale propugnato per l’umanità futura.
Ed ecco allora che il socialismo secondo Pascoli era investito di una missione civilizzatrice, là dove civiltà significava vittoria dell’uomo contro i suoi istinti ferini e primitivi. Il socialismo scientifico di Marx portava in sé il germe del fallimento perché pretendeva perseguire la giustizia su presupposti razionali, mentre soltanto l’amore avrebbe rivoluzionato gli animi e, insieme ad essi, avrebbe segnato un nuovo assetto societario. Il socialismo come fatto d’amore. E questa non fu un’aporia, ma un’intuizione potenzialmente feconda, realizzabile cioè, versando l’amore e laicizzandolo in solidarietà, comune responsabilità, come socialismo attuato nelle socialdemocrazie. Anche perché gli uomini, sperduti in un cosmo incomprensibile e soli davanti alla morte, non avrebbero potuto non sentirsi e riconoscersi fratelli (come nell’Era nuova, discorso messinese del 1899). Qui il suo socialismo odorava di Ginestra leopardiana: la social catena davanti al destino.
La convinzione dell’inutilità, e anzi, della perniciosità della lotta di classe, che pure rappresenta il fondamento della dottrina socialista, è l’elemento più peculiare del pensiero politico pascoliano, un elemento che forse gli derivava anche dai precetti massonici di fratellanza universale. La lotta di classe in quanto lotta dell’uomo contro l’uomo era per lui inconcepibile e causa di ogni male presente e futuro, e ugualmente erano incomprensibili i contrasti tra partiti, dunque ne sarebbe stata inficiata ogni vita politica reale.
È una visione originale e personale al tempo stesso, perché il figlio di una famiglia troppo precocemente spezzata, e di nuovo andata in frantumi con il tradimento di Ida, non poteva non auspicare l’armonia della più grande famiglia umana, non poteva non volere che tutti i nidi, individuali e collettivi, restassero integri e al sicuro dagli artigli di potenziali predatori. Siffatte prese di posizione si riverberano anche sulla lettura che del Risorgimento Pascoli diede, complice pure il calendario, giacché il 1911 fu l’anno santo della patria: e così il Risorgimento pascoliano, quello degli omonimi Poemi, editi postumi nel 1913, fu anche un Risorgimento d’occasione, e che fosse d’occasione si avverte nella poematicità contorta, nella struttura laboriosa, negli esiti raramente felici, in una complessione astratta, dettata da circostanze e da doveri di teoria politica e rappresentatività sociale.
La poematica risorgimentale divenne un luogo storiografico in cui sanare le crepe e conciliare gli opposti, miracolare il processo risorgimentale in una convergenza di armoniche sfere politiche, Cavour e Garibaldi, Mazzini e Vittorio Emanuele II, repubblica e monarchia, rivoluzione e diplomazia, senza polemiche e senza attriti, senza fazioni e senza recriminazioni. Insieme. Perché è così che doveva essere una famiglia. E la famiglia Italia, concelebrante la messa della patria Giovanni Pascoli, unita doveva essere e compatta, sotto l’egida dei suoi numi tutelari. Non solo. Anche storie millenarie partecipavano a quell’evento, tanto che la storia pascolianamente svaniva in mito e leggenda.
Galleria



Bibliografia di riferimento
- R. Zangheri, Documenti del socialismo giovanile di Giovanni Pascoli, in Studi per il centenario della nascita di Giovanni Pascoli, a cura di R. Spongano, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1962, vol. I, pp. 81-99.
- A. Varni, Il giovane Pascoli e il socialismo, in «Rivista Pascoliana», 1992, pp. 27-34.
- E. Graziosi, Pascoli edito e ignoto: «Colore del tempo», in «Rivista Pascoliana», 1993, pp. 93-119.
- E. Graziosi, Pascoli edito e ignoto: sonetto per Sveno, in «Giornale Storico della Letteratura italiana», Vol. CLXXV, fasc. 571, 1998, pp. 396-415.
- M. Marcolini, Pascoli prosatore. Indagini critiche su “Pensieri e discorsi”, Modena, Mucchi, 2002.
- AA. VV., Pascoli socialista, a cura di G. M. Gori, Bologna, Patron, 2003 (con saggi di Maurizio Ridolfi, Roberto Balzani, Antonio Montanari, Elisabetta Graziosi, Marino Biondi, Mario Pazzaglia, Renato Barilli, Dino Mengozzi).
- E. Graziosi, Pascoli edito e ignoto: inno per l’Internazionale anarchica, in «Giornale Storico della Letteratura italiana», Vol. CLXXXIV, fasc. 606, 2° trim. 2007, pp. 272-81.
- A. Cencetti, Giovanni Pascoli. Una biografia critica, Firenze, Le Lettere, 2009.
- M. Biondi, La tradizione della patria. II. Carduccianesimo e storia d’Italia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010.
- AA. VV., Pascoli. Poesia e biografia, a cura di E. Graziosi, Modena, Mucchi, 2011 (con saggi di Elisabetta Graziosi, Alice Cencetti, Massimo Castoldi, Carla Chiummo, Patrizia Paradisi; e testimonianze di Gian Luigi Zucchini, Renata M. Molinari, Silvana Strocchi, Sergio Tisselli).